Secondo il Tribunale di Ivrea gli insulti a colleghi e superiori pubblicati su Facebook sono una causa sufficientemente grave da giustificare il licenziamento di un dipendente.
Con ordinanza del 28 gennaio 2015, il Tribunale di Ivrea ha rigettato il ricorso di un ex-dipendente che chiedeva il reintegro al lavoro in seguito ad un licenziamento per giusta causa. Il collaboratore era stato licenziato per aver postato su Facebook pesanti ingiurie nei confronti dei datori di lavoro e di alcune colleghe.
Il ricorrente, pur ammettendo di aver pubblicato sulla propria bacheca di Facebook le offese, si era rivolto al tribunale sostenendo che tale condotta non poteva essere considerata così grave da giustificare il licenziamento e chiedendo, oltre al reintegro, un indennizzo risarcitorio.
Si tratta del secondo procedimento che vede l’impiegato ricorrere in giudizio per chiedere il reintegro lavorativo presso la stessa azienda. Il rapporto di lavoro era infatti già stato interrotto nel 2012. Tuttavia, alcune irregolarità nei contratti avevano portato l’uomo ad intentare un ricorso e alla fine del 2012 il Tribunale aveva accolto la sua richiesta, annullando i termini di collaborazione a tempo determinato che aveva stipulato con la società e condannando la stessa al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate.
Nel 2014 l’azienda aveva quindi riassunto il dipendente, ma aveva deciso di esonerarlo dal rendere effettivamente la prestazione lavorativa, e di fatto il collaboratore aveva iniziato a ricevere uno stipendio senza dover lavorare.
Paradossalmente questa condizione, che ad alcuni potrebbe sembrare vantaggiosa, ha portato il dipendente a diffamare i propri datori di lavoro su Facebook. L’uomo ha infatti pubblicato sul social network la lettera di riassunzione, accompagnandola con espressioni altamente ingiuriose nei confronti dei superiori che lo avevano reintegrato e di alcune colleghe.
Come il giudice del Tribunale di Ivrea ha sottolineato, i post non erano riservati agli “amici” del ricorrente, ma erano “potenzialmente visibili dal circa miliardo di utenti del social network” e sono stati rimossi solo in seguito ad una diffida da parte dell’azienda. Questi fattori hanno pesato sulla decisione finale del giudice, secondo cui la gravità della condotta dell’ex-dipendente è da considerarsi “tanto grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.”
Nell’ordinanza viene esplicitato che le ingiurie, e soprattutto gli insulti sessisti proferiti ai danni delle colleghe del tutto estranee al precedente contenzioso tra i datori di lavoro e l’impiegato, denotano “la volontà del ricorrente di diffamare sia la società, sia parte dei dipendenti, con le modalità potenzialmente più offensive dell’altrui reputazione.”
Invano il ricorrente aveva tentato di giustificare la sua condotta come “una reazione, anche se eccessiva ed abnorme (ma anche istintiva)”. Il giudice ha osservato che se fosse stata generata da un gesto istintivo –anche se inconsulto – il dipendente avrebbe provveduto all’eliminazione dei post prontamente e non dopo oltre due settimane, come in realtà accaduto. Questa lunga permanenza online dei commenti sembrerebbe inoltre suggerire da parte del ricorrente la mancata percezione della gravità del proprio comportamento.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato con ordinanza il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’azienda, liquidate in euro 3.500.
La decisione del giudice del tribunale di Ivrea conferma l’orientamento giurisprudenziale del licenziamento per giusta causa per post denigratori a danno del datore di lavoro, come già stabilito dalla Corte d’Appello di Torino (sentenza del 17 luglio 2014, n. 164) e dalla sezione lavoro del Tribunale Milano (ordinanza del 1 agosto 2014).
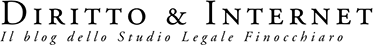











Aggiungi commento